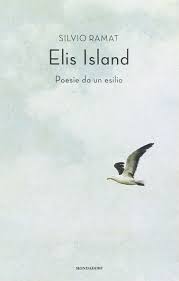Ellis Island era il luogo,
tristemente famoso, di passaggio obbligato, di smistamento e selezione, nonché
di quarantena, per tutti coloro che tra Otto e Novecento hanno sperato, da
immigrati, di costruirsi una vita negli Stati Uniti. Del tutto normale, quindi,
che si prestasse a diventare un’efficace metafora letteraria (ricordo, poco più
di una decina d’anni fa, un allestimento operistico di Giovanni Sollima su
libretto di Roberto Alajmo). Nella reinvenzione di Silvio Ramat, un poeta che
ha avuto una lunga esperienza d’insegnamento universitario come uno dei massimi
conoscitori della poesia moderna e contemporanea, grazie alla caduta di una
«l», diventa oggi il titolo di un’opera ibrida, di un prosimetro, idealmente
scritto a quattro mani con una collega, Elisabetta (Elis, appunto) con la quale
avvia una folta corrispondenza in versi e in prosa.
Elis Island è dunque l’ultima fatica di Ramat. I due protagonisti
vivono lontani e non si incontrano, ma rievocano, nel loro corrispondersi,
eventi del loro passato comune, letture distanti e ancora fertili, ossessioni,
finanche canzoni. Tutto un mondo condiviso si riaffaccia nelle loro missive: è
lui che le scrive in versi, stabilendo un patto fin dal principio; lei si
presta al gioco e risponde in prosa. Anche Elis ha insegnato all’università, ha
diviso la sua vita fra viaggi e continenti, così che l’intesa tra i due si fa
profonda, empatica. Lui scrive da un luogo mai nominato né specificato:
immaginiamo una clinica, un sanatorio, dove è rinchiuso per una lunga convalescenza,
non sappiamo neppure in seguito a cosa. Nulla, insomma, ci viene detto di
quanto è accaduto, ma solo di quanto accade di lettera in lettera, di risposta
in risposta. Neppure Elis ne è a conoscenza, e seppure ogni tanto lasci
trapelare qualche accenno di curiosità, sa che deve stare nel suo ruolo.
Non c’è in realtà alcun mistero,
o reticenza. Forse, al massimo, un residuo di pudore, di educazione e di
civiltà che sembra rinviare, non senza qualche malinconia, a ben altri tempi.
Il luogo non detto, dove avviene ogni tanto qualche strana apparizione di
medici o infermieri, sui quali il racconto si limita appena ad accennare, non è
il mancato protagonista alla Mann di questo libro, ma ne è soltanto il
pretesto. Protagonista è invece la scrittura, nella sua azione, nel suo stesso
farsi. È quello il canale posto in evidenza. È quella l’«isola» sul cui terreno
i due corrispondenti possono infine ritrovarsi, rievocando liberamente i loro
trascorsi e riaffermando così le rispettive identità. Il testo si muove dunque
dall’interno verso l’esterno dove si trova Elis, ma anche dall’interno dei loro
passati verso un presente difficile e confuso. I loro ricordi e le loro
reciproche introspezioni si fanno materia del narrato, lo sostanziano, in un
preciso gioco delle parti al quale i due protagonisti rimangono fedeli per
tutto il libro. Solo la guarigione, infine intravista, consente l’arrivo della
fine: e come nulla ci viene detto del prima, nulla ci viene detto del dopo. La
corrispondenza si interrompe quando la quarantena della scrittura non è più un
obbligo e l’isola del prosimetro può essere abbandonata da entrambi. Con il suo
consueto stile colloquiale e musicale, Ramat ha congedato un’opera di grande
suggestione, abbracciando una vasta geografia anche sentimentale.
Silvio Ramat, Elis Island,
Mondadori, 2015, e.15.00
XIX.
Amica tentatrice, se rimuovi
cenere e macerie dall’edificio
di un’adolescenza fin troppo
lunga,
sappi che nel ballo – malgrado avessi
un buon orecchio, dicevano – mai
vinsi nelle movenze una
goffaggine
ch’era anche timidezza…
Consapevole
di questo limite, al cambio del
disco
mi mettevo nell’angolo più in
ombra
della sala (di solito eravamo
in casa di una compagna di
scuola)
e lì, in piedi, atteggiandomi a
infelice,
aspettavo qualcuna, un cor
gentile,
che mi rinfrancasse, gesti e
parole.
Feste così ormai non se ne dànno
ma, sotto un’altra pelle, la mia
vita
è goffa come allora e ha quell’affanno.